 Danni
uditivi
Danni
uditivi
Perdita progressiva delle
capacità uditive
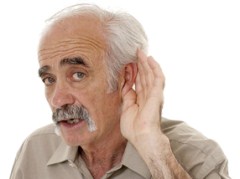 L’esposizione prolungata a rumore di
elevata intensità può produrre una diminuzione delle capacità uditive, le cui
entità variano asseconda delle diverse suscettibilità individuali. Questo
fenomeno avviene, di norma, in due fasi. Nella prima fase, si registra nel
lavoratore un abbassamento temporaneo della soglia uditiva. Nella seconda fase,
che può durare mesi o anni, in funzione della “dose” di rumore assorbita e dei
tempi di recupero, l’abbassamento temporaneo della soglia uditiva rientra sempre
più lentamente, fino a quando diventa un fattore permanente.
L’esposizione prolungata a rumore di
elevata intensità può produrre una diminuzione delle capacità uditive, le cui
entità variano asseconda delle diverse suscettibilità individuali. Questo
fenomeno avviene, di norma, in due fasi. Nella prima fase, si registra nel
lavoratore un abbassamento temporaneo della soglia uditiva. Nella seconda fase,
che può durare mesi o anni, in funzione della “dose” di rumore assorbita e dei
tempi di recupero, l’abbassamento temporaneo della soglia uditiva rientra sempre
più lentamente, fino a quando diventa un fattore permanente.
Solamente se esposti a livelli di pressione
sonora molto elevati (SPL > 150 dB e Peack > 160-170 dB) è possibile contrarre
un danno uditivo immediato, spesso accompagnato dalla rottura del timpano. Per
tutti gli altri casi, la relazione che lega la dose assorbita di rumore e il
danno uditivo, si basa sul principio dell’Eguale Quantità di Energia,
secondo cui il deficit uditivo è proporzionale al prodotto tra il tempo di
esposizione e il quadrato del livello di pressione sonora (relazione valida per
rumori di intensità fino a 115 dB).
Tuttavia, non è possibile quantificare
esattamente quanta parte abbia, nel determinare il danno uditivo, la dose di
rumore assorbita, poiché lo spostamento della soglia uditiva è prodotto dalla
risultante di più fattori: danno uditivo da rumore, invecchiamento naturale e/o
l’incidenza di malattie, sostanze ototossiche ed esposizioni a rumori
extra-professionali.
Presbiacusia e socioacusia
Con il passare degli anni le capacità
uditive tendono a diminuire. Tale processo prende il nome di presbiacusia,
dovuto agli sviluppi dell'invecchiamento, il quale determina un deficit uditivo
riguardante soprattutto le frequenze elevate (6-8 kHz).
L'entità di tale decremento uditivo è dato
dalla risultante di due fenomeni, ossia l'invecchiamento e l'ambiente di vita.
Da qui il termine di socioacusia, termine descrittore dei due processi
combinati, nell'ambito dei quali non è possibile scindere quanta parte sia
imputabile all'uno e quanta all'altro.
Le normative emanate in materia di limiti
di rumorosità negli ambienti di lavoro sono, per questo, basate sulla
valutazione del rischio, assunto dal confronto fra una popolazione "normale" e
una esposta professionalmente a rumore, in base ad un concetto di probabilità
che l'esposizione a determinate soglie di rumore possano creare una perdita
uditiva aggiuntiva.
Audiometria
Uno dei metodi diagnostici per la
valutazione del danno uditivo è rappresentato dall'audiometria liminare tonale,
la quale serve a determinare la soglia uditiva mediante l'invio al paziente di
toni puri nelle bande di frequenza d'ottava comprese fra 125 e 8.000 Hz.
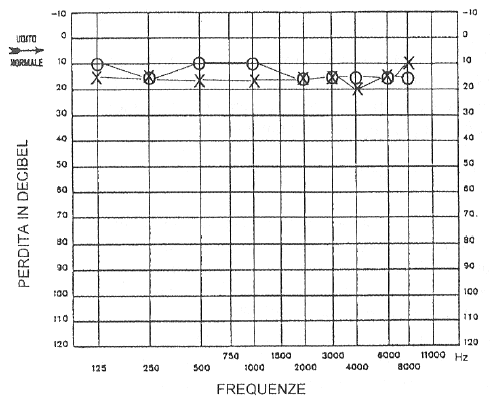
L'orecchio con udito normale ha come
livello sonoro di soglia il valore 0 dB che indica l'intensità minima di suono
percepibile. La perdita uditiva, o ipoacusia, espressa in deciBel esprime la
differenza tra il livello sonoro minimo che l'orecchio riesce a percepire e lo
zero, considerato convenzionalmente standard.
 L’audiogramma è il principale strumento
diagnostico in grado di quantificare l’effetto di una esposizione prolungata al
rumore nei confronti di un soggetto. Analizzato congiuntamente all’anamnesi
lavorativa e ai livelli di esposizione, fornisce importanti informazioni circa
le cause che hanno potuto determinare un deficit acustico.
L’audiogramma è il principale strumento
diagnostico in grado di quantificare l’effetto di una esposizione prolungata al
rumore nei confronti di un soggetto. Analizzato congiuntamente all’anamnesi
lavorativa e ai livelli di esposizione, fornisce importanti informazioni circa
le cause che hanno potuto determinare un deficit acustico.
L'audiogramma viene effettuato da un medico competente facendo
entrare il soggetto, al quale si vuole verificare un'eventuale danno al sistema
uditivo, in una cabina insonorizzata avente una pressione acustica interna pari
a circa 25 dB. Il medico attraverso delle cuffie calibrate fa giungere dei toni
puri a frequenze normalizzate aumentando gradualmente il volume del suono
Il danno da rumore è definito in base alla
diminuzione della capacità uditiva alle diverse frequenze. Nella fattispecie, un
soggetto si definisce “ipoacusico” qualora il deficit uditivo medio per le
frequenze 500, 1000 e 2000 Hz sia uguale o superiore a 25 dB.
|
torna
all'inizio |